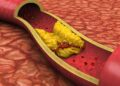Pubblicata sulla rivista Nature Communications, la ricerca rivela che questo meccanismo avviene nella corteccia entorinale, una parte del cervello fondamentale per l’apprendimento e la memoria e colpita dalla malattia di Alzheimer.
Il team guidato da Mayank Mehta ha utilizzato un approccio innovativo, un microscopio matematico, che si basa su modelli matematici applicati alla biologia. Grazie a questo strumento, è stato possibile osservare come la corteccia entorinale mantenga uno stato di inattività persistente durante il sonno, nonostante i segnali provenienti dalla neocorteccia. Si tratta della cosiddetta “memoria di lavoro”, che immagazzina le informazioni solo temporaneamente ed è praticamente sempre in funzione, si basa su un circuito che coinvolge lo strato più esterno del cervello, la neocorteccia, e regioni più profonde tra cui la corteccia entorinale. I ricercatori hanno osservato che i segnali provenienti dalla neocorteccia somigliano a onde che si formano e poi si infrangono sulla costa, mentre la corteccia entorinale è come un nuotatore che segue il movimento dell’acqua. Ma quando dormiamo, o siamo sotto anestesia, la corteccia entorinale rimane in uno stato di inattività persistente nonostante i segnali in arrivo, un meccanismo mai osservato prima.
L’aspetto straordinario della scoperta è che la combinazione di inattività persistente e attività ridotta permette di raddoppiare la capacità di memoria, riducendo al contempo il costo energetico. La ricerca apre nuove prospettive per comprendere i meccanismi della memoria e potrebbe avere implicazioni significative nella lotta contro l’Alzheimer.

Cosa succede al cervello quando si perde la memoria?
Quando si perde la memoria, il cervello mostra danni o deterioramento in aree chiave coinvolte nella formazione e nel recupero dei ricordi, come l’ippocampo e la corteccia entorinale. Queste alterazioni possono derivare da malattie neurodegenerative come l’Alzheimer, traumi cranici o altre condizioni. La perdita di memoria influisce sulla capacità di apprendere nuove informazioni e di richiamare ricordi passati, con conseguenze sulla cognizione e sulla vita quotidiana. Inoltre, possono emergere difficoltà nell’orientamento spaziale, nella comunicazione e nella gestione delle attività quotidiane.
Come fa il cervello a ricordare le cose?
Il cervello ricorda le cose attraverso la formazione e il consolidamento delle sinapsi, le connessioni tra i neuroni. Quando impariamo o viviamo un’esperienza, vengono attivati specifici gruppi di neuroni, creando tracce di memoria. L’ippocampo svolge un ruolo cruciale nel consolidamento di queste tracce, trasferendo i ricordi dalla memoria a breve termine a quella a lungo termine. Durante il sonno, in particolare durante la fase REM, il cervello rafforza questi collegamenti, facilitando il richiamo futuro. Le aree corticali immagazzinano le informazioni e interagiscono per recuperarle quando necessario.